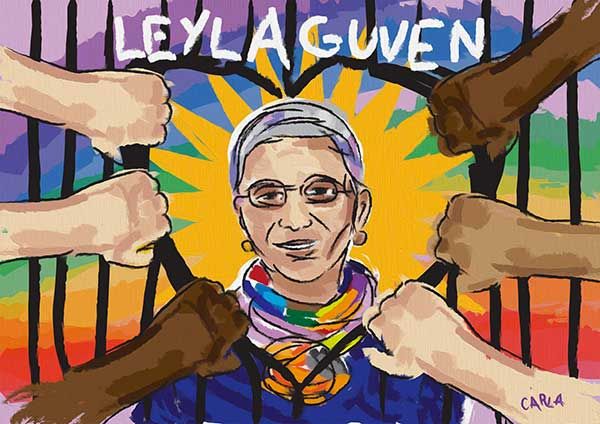“Il sogno del guerriero” è il nuovo murales dipinto dall’artista peruviano Carlos Atoche sul muro della scuola primaria Istituto Comprensivo Riace Monasterace di questo piccolo borgo della Locride, noto per essere stato un modello esemplare di accoglienza e di integrazione per i rifugiati che scappavano dalle guerre. Quest’opera straordinaria di 60 metri quadrati, visibile anche dalla piazza centrale del borgo, è stata sostenuta dal Comitato Riace Premio Nobel per la Pace e portata a termine grazie all’accoglienza di Riace e ai piccoli contributi donati attraverso l’appello pubblicato sulla pagina Facebook della Campagna.
Il murales raffigura un guerriero mitologico che esprime con la forza dei suoi tratti l’idea dell’accoglienza e del rispetto per lo straniero ed il viandante propria della mitologia greca, trapiantatasi nella Magna Grecia. Un guerriero forte che ama la sua gente ed il suo paese e che si batte per non farlo cadere nell’abbandono e per non farlo morire accogliendo chi scappa dall’inferno e sogna una nuova vita.
Quel guerriero dipinto con grande forza da Carlos con le sembianze e la possanza di uno dei bronzi, riemersi a distanza di secoli dal mare di Riace come per volere e disegno del “fato”, in realtà non è mai andato via. Come l’idea di accoglienza e di ospitalità che è rimasta viva attraverso i secoli nelle popolazioni dell’ex Magna Grecia e dell’intera Calabria nonostante le sue stridenti contraddizioni.
Il dipinto è un omaggio a Mimmo Lucano che è stato capace di tradurre il sogno in realtà trasformando il comune di Riace in un’esperienza unica di accoglienza e di rispetto per gli altri. Quel sogno che un pensiero politico di segno opposto, fondato sull’egoismo, la paura e la criminalizzazione della solidarietà sta tentando di soffocare, strozzando insieme le speranze di chi fugge dall’orrore e quelle di un intero paese che ha dato vita ad un percorso di speranza e di rinascita nel nome di una nuova Umanità.
Mimmo, senza processo, è confinato in esilio, come lo sono sempre stati nella storia i combattenti della libertà, ma le sue idee non sono andate via e l’arte di Carlos ce lo ricorda. Mimmo tornerà anche materialmente alla sua Riace diventata grazie a lui di tutti quelli e quelle che a Riace e nel mondo hanno lavorato e continuano a lavorare con lui, un’esemplare costruzione collettiva, di una migliore Umanità e di un’idea di sviluppo locale rispettosa di tutti gli esseri viventi e della madre Terra.
Il paese ha accolto con grande entusiasmo il nuovo murales, in molti sono venuti a complimentarsi con Carlos per il suo dipinto e hanno lasciato un messaggio di solidarietà e di vicinanza a Mimmo Lucano. Insieme a Carlos in questi giorni c’erano anche Emanuela Robustelli, curatrice d’arte che ha seguito tutta l’operazione assistendo l’artista Atoche e Maura Crudeli, presidente di Aiea Onlus, una delle associazioni promotrici del Comitato Premio Nobel per la Pace, che ha documentato la realizzazione del murales e curato la parte produttiva e logistica dell’opera.
Carlos Atoche ha incontrato Mimmo Lucano a Caulonia e racconta così la sua breve ma intensa esperienza a Riace: “È la prima volta che visito il paese e la mia prima impressione è stata quella di un borgo molto ordinato. Nell’aria c’è la sensazione di un luogo nel quale una volta c’era tanto movimento che ormai non c’è più: le strade e le piazze sono vuote, i negozi chiusi. Avvicinando il viso alle vetrine, ho intravisto molti spazi vuoti e sale dismesse. Ma questo paese, per quelli come me, che credono nell’inclusione come risposta al fenomeno dell’immigrazione in Italia, è diventato un simbolo, una speranza. Questo murales vuole essere fuoco che tiene accesa la scintilla del cambiamento.”
Mimmo Lucano guardando la foto del murales “La letteratura, la musica, l’arte sono espressioni della nostra anima, la bellezza della vita…la prima cosa che mi ha colpito quando ho visto la foto di questo murales è la luce. Mi sono immaginato che dalla piazza di Riace, dalla ringhiera dove tante volte mi sono appoggiato per guardare il mare, adesso gli occhi andranno ad incrociare questo spazio dove c’è l’anima di qualcuno che ha concepito questa cosa. Ho pensato a come emergesse questa figura che racconta la storia della nostra comunità, la figura della Magna Grecia, i bronzi di Riace.
A Riace altri artisti hanno raccontato sui muri la loro idea di accoglienza e hanno ricordato figure importanti che hanno lottato per la pace, per i diritti umani come Peppino Impastato o le Madri di Plaza de Mayo. Credo che sia un’aspirazione di tutti gli esseri umani immaginare un mondo di pace, un mondo senza confini, senza barriere. L’attuale periodo ci mette tanta tristezza perché ci vogliono far passare come ideali esattamente le cose opposte: chiudere i porti, rafforzare i confini, mettere i fili spinati, alzare i muri…e invece io ho un’altra utopia, io vorrei che non esistessero i confini e neanche i passaporti, ma a cosa servono i passaporti?!?
Ogni essere umano deve essere libero nel mondo, perché il mondo ha uno stesso cielo, uno stesso mare, una stessa terra per tutti. Ringrazio di cuore Carlos Atoche per questo murales, il suo dipinto ha donato bellezza e speranza alla nostra Riace”. E chiude con un appello “L’arte può esser uno slancio di utopia! Tutti gli artisti che vogliono venire a Riace a lasciare ognuno un loro piccolo segno sono i benvenuti. Anche Wim Wenders mi ha promesso che tornerà e questa cosa mi riempe d’entusiasmo, sulle ali di una nuova Calabria…!”